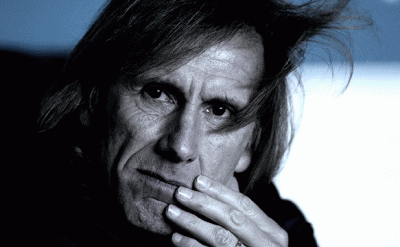[Torcida Grenal]
28 luglio 1983. L'Estadio Olimpico Monumental di Porto Alegre osserva i giocatori in maglia tricolore raccogliere il pallone calciato da Morena in fondo alla rete che fissa il risultato sull'1 a 1.
I gialloneri di Montevideo assaporano i supplementari e provano un poco meno di paura dopo il pareggio impostogli in casa la settimana precedente dal Gremio di Valdir Espinosa. I brasiliani, invece, si vedono tagliate le gambe dopo il generoso primo tempo che, tuttavia, aveva portato solamente la rete del puntero Caio. Sugli spalti, inizia a fare freddo. Un'aria che avvolge gelida chi non è nessuno e riscalda, invece, chi dal calcio ha già avuto tutto.
Poi un attimo, un silenzio. Renato Portaluppi, folta chioma nera e maglia aderente, alza la testa dalla fascia destra e vede l'inserimento di Cesar. Il cross è alto e morbido. Colpo di testa e rete. Scende l'avalanche. Si spezzano i sogni del Penarol ed il Gremio è campione del Sudamerica per la prima volta nella sua storia. Hugo De Leon, con la barba lunga nera, alza la Copa. Renato è invincibile, assieme a Valdo Filho e Tòffoli.
Quella che fino a quel momento era la migliore squadra dello Stato del Rio Grande do Sul ottiene così la consacrazione internazionale.
Qualche mese dopo, in dicembre, il Tricolor Gaucho si regala anche la Coppa Intercontinentale, battendo l'Amburgo di Magath Campione d'Europa. Ancora le magie di Portaluppi. Doppietta. E la torcida Geral intona finalmente il canto preferito Nada pode ser maior. Del Gremio.
 [Renato Portaluppi]
[Renato Portaluppi]
° ° °
Ad inizio secolo, in Brasile, il calcio era una questione per pochi.
Semplicemente, giocava a pallone chi ne possedeva uno. I pochi esemplari di cuoio viaggiavano assieme ai commercianti ed ai pastori.
A Porto Alegre, l'unico pallone era di un imprenditore paulista, un certo Candido Dias da Sorocaba. Narra la leggenda che questi assieme agli amici adorasse l'oggetto senza tuttavia comprenderne appieno le funzionalità. Successe poi che il principale club calcistico brasiliano fino a quel momento, lo Sport Club Rio Grande, fosse giunto in città proprio per offrire una dimostrazione del gioco del calcio. A metà dimostrazione il pallone degli stranieri si forò e Candido Dias, estasiato dallo spettacolo, offrì il suo in cambio del disvelamento delle regole del gioco del calcio. La settimana successiva alla partita poi, in un locale della zona del porto, il Salao Grau, decise di fondare una squadra di calcio. Nasceva così il Gremio Foot-Ball Porto Alegrense.
Nel marzo 1904 la prima uscita ufficiale contro un'altra squadra di Porto Alegre, il Fuss-Ball Club Porto Alegre, anch'esso fondato per attirare l'interesse della comunità tedesca della Regione, e poi tanti anni a livello amatoriale e il primo stadio: la Baixada dos Moinhos de Vento.
A partire dagli anni Dieci il Gremio iniziò a giocare anche contro squadre di altre regioni e Stati brasiliani e negli anni Quaranta sposò il professionismo.
Erano anni di transizione. Veniva inaugurato il nuovo stadio, l'Olimpico Monumental, e per lo più il Gremio provò a conquistare l'egemonia regionale tra il Campionato Gaucho e quello di di Porto Alegre e a vincere più scontri possibili contro i rivali dell'Internacional.
Solamente a inizio anni Ottanta il vento iniziò a cambiare, a soffiare più forte.
° ° °
Per il Brasileirao del 1981 si siede sulla panchina del Gremio un grande del calcio brasiliano: Enio Andrade. Qualche anno prima aveva vinto il campionato con il Colorado e ad oggi è uno dei quattro allenatori che sono riusciti a vincere per tre o più volte il titolo: solo Muricy Ramalho (quattro affermazioni con San Paolo e Fluminense) e Vanderlei Luxemburgo (cinque con Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro) lo precedono nel novero degli allenatori più vincenti in Brasile.
Negli anni Ottanta, il campionato brasiliano era una specie di guerra infinta e si chiamava Trofeo d'Oro (Taca de Ouro). Le 40 squadre che vi prendevano parte erano suddivise in 4 gironi. Turno unico e passaggio del turno per le prime 7 classificate. Seconda fase ancora a gironi. Alle 28 squadre qualificate nel turno precedente si aggiungevano le 4 prime classificate della Taça de Prata, la competizione brasiliana di serie B: si formavano così 8 gruppi di 4 squadre ciascuno. Andata e ritorno e passaggio del turno per le prime 2 classificate. La fase finale, infine, prevedeva l'eliminazione diretta. E andata e ritorno fino alla finale.
Alla prima fase, il Gremio pesca un girone abbordabile e nonostante le sconfitte con il Brasilia e l'Operario di Campo Grande (città dello Stato di Mato Grosso do Sul) si qualifica per il gruppo successivo. Come quarto classificato, il Gremio viene inserito nel girone con San Paolo, Fortaleza e Inter de Limeira. E gli uomini di Andrade partono malissimo, perdendo in casa del Tricolor Paulista per 3 a 0. Si rifanno sul Fortaleza ma cascano nuovamente sotto i colpi dell'Inter. Poi la svolta. Altri 4 punti al ritorno con il San Paolo e al Castelao di Fortaleza. Infine, arriva anche la vendetta sull'Inter, 1 a 0. Il Gremio passa il turno come seconda classificata e approda agli Ottavi. Dove incontra il Vitoria della Città di Salvador. Sconfitta di misura in trasferta e 2 a 0 secco tra le mura amiche. Arrivano i Quarti: di nuovo l'Operario. Il Tricolor Gaucho si impone in tutti e due gli scontri senza mai lasciare il gioco agli avversari, guadagnandosi una difficile Semifinale con il Ponte Preta.
All'Olimpico Monumental, Tarciso, Tadei e Izidoro, rispondendo alla doppietta di Lola, inchiodano il punteggio sul 3 a 2 per il Gremio. A Campinas, la banda Andrade soffre, ma perde solamente 1 a 0, qualificandosi alla Finale in virtù del miglior risultato al turno precedente (il Ponte Preta, infatti, aveva superato il Vasco di Dinamite ai Quarti in virtù dello stesso criterio, non piazzando gol di scarto).
In Finale, ancora il San Paolo.
Il Gremio va subito sotto in casa - gol di Chulapa - ma reagisce e tra il 59 ed il 69 piazza la doppietta di Izidoro, guadagnando il vantaggio in vista del ritorno.
E in un Morumbì stracolmo (95.000 spettatori) una lancia scagliata da Balatazar (anche Pichichi della Liga in maglia colchonera) colpisce al cuore la squadra paulista. Il Gremio di Andrade è campione del Brasile.
 [Baltazar]
[Baltazar]
La vittoria del campionato nazionale regala la qualificazione alla Copa Libertadores dell'anno successivo. Alla sua prima apparizione in competizioni internazionali, tuttavia, il Gremio viene subito eliminato, complice la presenza nel girone del primo turno del Penarol, poi campione sui cileni del Cobreloa.
Nel campionato dell'anno successivo (1982) il Gremio raggiunge nuovamente la finale, contro il Flamengo di Zico, ma perde al terzo scontro (l'andata era finita 1 a 1 e il ritorno 0 a 0). La qualificazione alla Finale però garantisce lo stesso l'accesso alla Libertadores '83. Quella che lancerà tra i grandi Renato Portaluppi, portando il trionfo contro il Penarol.
° ° °
Negli anni successivi alla sbornia internazionale, il Gremio non riesce più ad imporsi a livello nazionale, bensì solo in ambito statale. Arrivano 7 Campionati Gaucho e poco più.
Serve il ritorno ad alti livelli. Serve una svolta.
E' il 1993 e la dirigenza pensa a un nome già passato dalle parti del Monumental qualche anno prima. Luis Felipe Scolari. 45enne, con esperienze in squadre minori e all'estero, in Arabia Saudita e Kuwait. Nel '91 Luis aveva vinto la Coppa del Brasile con una squadra praticamente sconosciuta, il Criciuma.
All'esordio con il Gremio nel Brasileirao, Scolari stecca. non superando la prima fase a gironi. Quel Campionato si rivelerà poi affare del Palmeiras di Zago, Roberto Carlos ed Edmundo.
L'anno successivo, il Gremio si conferma incapace di accedere alla seconda fase. Ancora una volta vince il Palmeiras, che ha ora Rivaldo ad affiancare 'O Animal. Capocannoniere della competizione è invece un ragazzetto del Guaranì da gol estremamente facile di nome Marcio Amoroso.
La vittoria della Copa de Brasil però salva la panchina di Scolari e porta il Gremio di nuovo in Libertadores.

[Luiz Felipe Scolari]
A metà anni Novanta, la Libertadores aveva una formula particolare. Ogni Paese partecipava con due squadre che venivano accoppiate in girone con le due squadre di un altro Paese. Le prime tre di ciascun girone avrebbero poi occupato posizioni vicine nella griglia degli Ottavi. Questo rendeva assai probabile i derby ai Quarti e la presenza di 4 Paesi diversi in Semifinale. Il Brasile venne accoppiato all'Ecuador e Palmeiras e Gremio si trovarono di fronte Emelec e Nacional.
La dirigenza decide di investire e regala a Scolari Mario Jardel, un giovane di vent'anni cresciuto nelle giovanili del Vasco da Gama, e il paraguaiano Francisco Arce per la fascia. A questi si aggiunge il centrocampista offensivo Mocellin Magno, in prestito dal Flamengo.
La poco collaudata truppa di Porto Alegre fatica nel doppio scontro con il Palmeiras - perde all'andata e pareggia al ritorno - ma ha gioco facile contro gli ecuadoriani. L'Emelec impone il pareggio per 2 a 2 a Guayaquil (Paulo Nunes e Jardel) ma viene sommerso di gol al Monumental (Jardel, Luciano, Paulo Nunes e Magno), El Nacional viene affossato all'Olimpico Atahualpa da una doppietta di Arce e regolato in Brasile da Jaques e Mocellin Magno.
Il Gremio chiude secondo davanti all'Emelec e a un soffio dal Palmeiras.
Agli Ottavi il Tricolor incontra l'Olimpia di Asuncion, prima nel girone Paraguay-Venezuela e decide di farsi bello. 3 reti in trasferta, 2 in casa. Mario Jardel è scatenato e si rivela un incubo per i difensori paraguaiani. La torcida è titubante. Il Gremio fa paura, ma sembra tutto troppo bello e casuale. E ai Quarti c'è di nuovo il Palmeiras. La squadra delle stelle, la migliore formazione del Sudamerica negli anni Novanta. Edmundo è passato al Flamengo ma lo ha rimpiazzato un campione del mondo: Luiz Antônio Correia da Costa, in campo, per tutti, Müller. Sulla fascia destra poi c'è un altro nome nuovo, Cafù.
All'andata, in un Olimpico Monumental esaurito in ogni ordine di posti, il Gremio esagera. L'uno-due Arce-Arilson a ridosso dell'intervallo taglia le gambe ai paulisti. Mario Jardel ne infila tre a metà ripresa. 5 valanghe, 5 boati assordanti. Scolari in panchina si gode il suo gioiello. Il Palmeiras è annichilito.
Al ritorno, alla Palestra Italia di San Paolo, il gol di Jardel in apertura dovrebbe essere il preludio ad un altro trionfo. Sembra diventato tutto facile per il Gremio. Troppo facile. Il Palmeiras ferito reagisce e in batter d'occhio ribalta il risultato con Cafù (partito in posizione dubbia) e Amaral. Ad inizio ripresa Paolo Isidoro segna il 3 a 1. Ora gli uomini di Carlos Alberto Silva ci credono. Al Tricolor iniziano a cedere le gambe. Il tifo assordante spinge in rete anche il rigore calciato dall'argentino Alejandro Mancuso, 4 a 1. E' il 69esimo e per il Gremio il tempo non scorre. Ancora Cafù, gol strepitoso. Al minuto 84.
I successivi 6 minuti più recupero credo siano un graffio nella mente di qualunque tifoso del Gremio. I minuti del dolore, i minuti interminabili. Poi il fischio di Pereira e il passaggio del turno. Per uno sporco gol in mischia di Jardel in apertura.
 [Mario Jardel]
[Mario Jardel]
Lasciata l'angoscia alle spalle, il Gremio si concentra sulla Semifinale. Ancora l'Emelec, che nel frattempo ha faticato contro il Cerro Porteno, battendolo solamente ai calci di rigore, e vinto facile con lo Sporting Crystal di Lima. Come nella prima fase, gli ecuadoriani impongono il pareggio tra le mura amiche ma si sciolgono in terra brasiliana. I gol sono del solito Jardel e di Paulo Nunes. Il Gremio è in Finale.
Di fronte la sorpresa della competizione. Quell'Atletico Nacional di Medellin che agli Ottavi ne ha fatti 6 al Penarol, ai Quarti ha superato di misura Los Millionarios di Bogotà e in Semifinale si è concesso il lusso di eliminare ai rigori il River Plate.
Per la gara di andata, il Monumental è esaurito. Scolari ripropone la coppia d'attacco delle meraviglie con Arilson e Dinho a creare in mezzo al campo. I colombiani si affidano invece alla stella Juan Pablo Angel e ai capelli di Renè Higuita. L'Atletico parte forte e prova ad impostare la partita. Il Gremio gestisce e ogni tanto riparte. Tra il 36' ed il 43', la svolta. Prima un cross morbido dalla destra incontra la sfortunatra deviazione di Marulanda, poi Jardel raddoppia in mischia. In un istante il Gremio schiaffeggia l'Atletico. In un istante, il Monumental tocca il cielo. Ad inizio ripresa arriva anche il timbro di Paulo Nunes. Hernán Cadavid Gónima, il coach colombiano, scuote la testa, invocando la speranza. Angel lo accontenta e firma la rete che riapre il doppio scontro. Finisce 3 a 1.
Una settimana dopo, Medellin è un'immagine terrificante. Il manto erboso mezzo bruciato, i fumogeni ed un frastuono assordante. E l'Atletico che parte fortissimo.
Scolari è pensieroso e impreca al tiro alto di Jardel lanciato da solo in contropiede. Sente che gli manca il respiro quando al 12' i colombiani feriscono Danrlei. E' un confuso capolavoro di precisione l'azione che porta al gol di Aristizabal. E' un tocco sotto micidiale: all'Atletico manca un gol per aggiudicarsi la Copa e questa volta i minuti alla fine non sono 6, sono molti molti di più. Il Gremio però reagisce e tiene il campo. Il tempo scorre e i battiti del cuore aumentano.Poi un attimo, come più di dieci anni prima. La corsa di Jardel verso l'area avversaria. Gli strattoni presi e dati. L'ingresso in area ed il fallo del difensore colombiano. Il cileno Imperatore fischia rigore e Dinho, i capelli radi e l'aria di chi ha già scelto l'angolo, sistema il pallone. Il silenzio, come sul cross di Portaluppi. E l'urlo ad Higuita battuto.
° ° °
L'anno dopo Medellin, il Gremio vinse la Recopa Sudamericana contro l'Independiente di Burruchaga. Poi Felipao scappò in Giappone, al Jubilo Iwata. Qualche anno dopo vincerà la Coppa del Mondo con il Brasile, grazie ad un Ronaldo stratosferico. Jardel tentò la fortuna in Europa insieme a molti altri giocatori di quel Gremio campione
La storia recente dell'Imortal Tricolor non parla di trofei. Qualche grande nome, as musas e tante delusioni. La sconfitta in Finale di Libertadores nel 2007, contro il Boca, e la vittoria dell'odiato Internacional sul Gauadalajara lo scorso anno. Infine, la recente eliminazione, sempre in Copa, per mano dell'Universidad Catolica, con Renato in panchina.
La storia recente parla di schiaffi e crisi finanziarie. Il cuore della torcida Grenal però batte ancora forte. Per quei sei minuti contro il Palmeiras. Per la gioia di Jardel e per le botte da fuori di Arce. Perchè il Nal non regni. Perchè ancora una volta nulla possa essere più grande. Del Gremio.

[Natália Anderle, musa do Gremio]